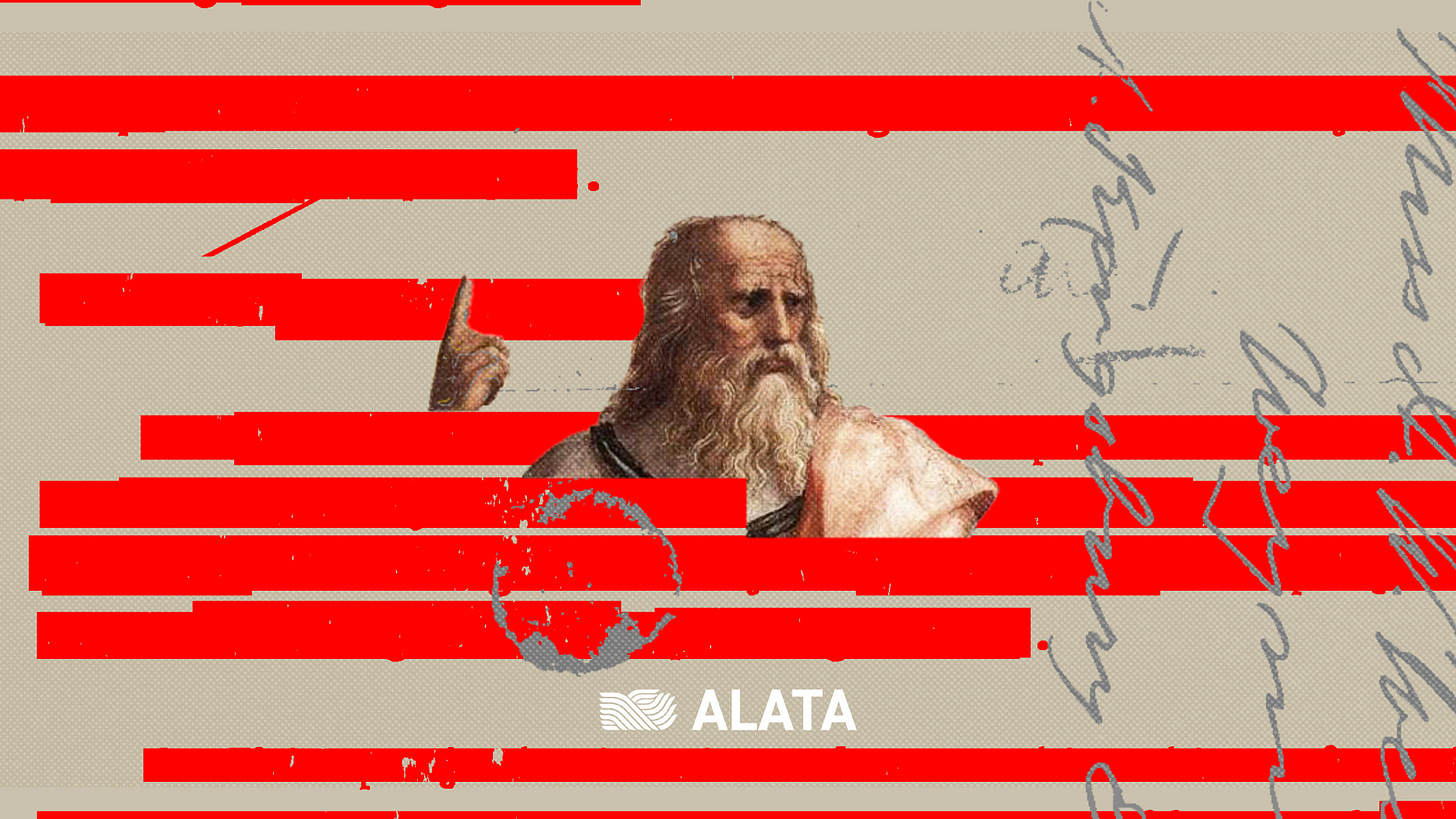Poeti Ribelli: L'Importanza della Scrittura per la Libertà
Platone credeva nella censura della passione, vediamo lo stesso accadere oggi?
La Repubblica di Platone, scritta nel IV secolo a.C., è alla base non solo della filosofia politica e della forma di governo degli Stati Uniti ma anche della democrazia occidentale nel suo complesso. Se i Padri fondatori hanno preso in prestito molte delle idee di Platone sulla democrazia per redigere la Costituzione degli Stati Uniti, fra la società americana e quella descritta nella Repubblica vi è però una grande differenza, che riguarda la promozione della libertà di espressione. Nel censurare i poeti, Platone voleva vietare la libertà di parola. Perché?
La Repubblica ci offre una strana definizione della scrittura, che ci aiuta però a comprenderne l'importanza oggi. Il testo di Platone è ricco di riflessioni epistemologiche e di prescrizioni legislative – dall’allegoria della caverna del libro VII, amata dai professori di filosofia di Philosophy 101, all'introduzione della figura del Re Filosofo, nel Libro V. La posizione di Platone sui poeti, presentata nel Libro X, è forse una delle sue più memorabili. Secondo il filosofo, i poeti - e, per estensione, chiunque scriva per scopi diversi dalla contabilità o da questioni governative - non hanno posto nella sua società ideale.
Per provare a comprendere il disprezzo di Platone per i poeti, occorre prima comprenderne il principale contributo alla tradizione filosofica occidentale: la sua teoria delle idee e la sua difesa della verità oggettiva.
La teoria delle idee di Platone appare soprattutto – nella sua forma più famosa – nell'Allegoria della caverna della Repubblica: dopo aver visto una processione di ombre sulla parete di una grotta, il prigioniero che esce dalla caverna entra in contatto con il mondo fisico che lo circonda e fa esperienza di una rappresentazione della realtà più accurata di quella offerta dalle ombre. Le ombre (o simulacri) di Platone rappresentano un'immagine errata della verità oggettiva. Platone sostiene che il nostro mondo - che il prigioniero arriva a comprendere dopo la fuga dalla caverna - è una mera collezione di rappresentazioni imperfette di oggetti, come quelle ombre, che hanno forme ideali. Per giungere a una comprensione più completa della verità oggettiva dobbiamo sforzarci di cogliere le forme ideali che stanno dietro alle rappresentazioni, ovvero l’unica versione “corretta” della realtà.
Se l'obiettivo primario di un filosofo è quello di comprendere il mondo nei termini della sua iterazione più ideale, la scrittura, nel suo tentativo di rappresentare la realtà, soffre degli stessi problemi delle ombre sul muro della caverna, impedendoci di raggiungere la verità “oggettiva”. I poeti agiscono a molti gradi di distanza da questa verità, oltre a correre il rischio di infiammare le passioni di coloro che li leggono. Le passioni per Platone offuscavano la ragione, l’unico mezzo per comprendere le forme ideali.
In effetti in un altro dialogo, il Fedro, il Socrate platonico paragona l'esperienza della lettura all’osservazione di un quadro. Un dipinto, sostiene il filosofo, è una mera rappresentazione della realtà che sta in “solenne silenzio” e, senza poter fornire una rappresentazione fluida del mondo attorno a noi, non è in grado di comunicare la verità. Non è chiaro, spiega Socrate verso la fine del Fedro, se la scrittura, riflesso dell'esperienza interiore e quindi intrinsecamente non verificabile, sia una rappresentazione accurata della verità.
I poeti, sostiene Platone, sono particolarmente inclini alla menzogna e rappresentano perciò la più grande minaccia per una società stabile e funzionante che crede in un'unica verità oggettiva – cioè la società che il filosofo ci propone nella Repubblica. I poeti possono, dunque, recare i più grandi danni, perché le esperienze soggettive ci portano a mettere in discussione le verità prestabilite e potrebbero destabilizzare del tutto la società, rovesciando lo status quo.
Possiamo comprendere meglio la posizione di Platone contro i poeti, se consideriamo la scrittura, nella sua essenza, come un'espressione del mondo soggettivo – una sfida a una realtà già proposta. La scrittura diventa una minaccia per la società proprio perché disturba un ordine già stabilito – perché permette di introdurre punti di vista dissidenti. Se dobbiamo credere all'affermazione del filosofo politico inglese H.B. Acton, secondo cui il mondo della Repubblica è uno Stato autoritario, in cui regna l’ordine e la realtà oggettiva non può essere messa in discussione, la scrittura è, forse, il miglior antidoto al controllo: è una richiesta di libertà.
Duemila anni dopo Platone, il filosofo francese Jacques Derrida prese le difese della scrittura contro il filosofo greco. Nella sua opera Della grammatologia (1967), Derrida proclama che il mondo occidentale ha operato in gran parte all'ombra di Platone, ingiustamente svalutando la scrittura come inferiore al dialogue della parola. Così venne stabilito un ordine “logocentrico”, restrittivo, in cui la parola parlata regna suprema sopra la scrittura. Derrida cita il disprezzo di Platone per la scrittura già nei primi capitoli della sua Della grammatologia e spiega la generale diffidenza dell'Occidente nei confronti della scrittura per la capacità di quest'ultima di aprire il mondo a interpretazioni che potrebbero deviare da un una singola immagine di un unico ordine politico e sociale.
Nonostante abbia personalmente alcune critiche da muovere a Derrida - che concepisce la scrittura più come una scusa per rovesciare la “tradizione metafisica occidentale” che come un modo per promuovere la libertà – ammetto che il filosofo francese tocca un punto chiave, che prende in prestito da Platone ma che presenta sotto una luce diversa: la scrittura disturba l'ordine sociale. Ma, in contrasto con il pensatore ateniese, Derrida celebra la scrittura come il metodo principale attraverso il quale possiamo rendere giustizia all'esperienza soggettiva e utilizzare le nostre diverse comprensioni del mondo per liberare la società da un modello di pensiero unico e prestabilito.
Scrivere è il miglior strumento a nostra disposizione per continuare a difendere una società libera e democratica che permetta a tutti i propri membri, individualmente, di provare a dare un senso all'universo tramite la creatività e, così facendo, esprimere il proprio punto di vista. La scrittura è perciò l'antitesi dell’ordine totalitario, perché permette di praticare il dissenso – basta saper leggere e scrivere.
Ma perché la scrittura è così centrale per preservare una società libera? Come sostiene Benjamin Franklin, “senza libertà di pensiero non può esserci discernimento; e non può esistere libertà pubblica senza la libertà di parola.”
La libertà pubblica, in altre parole, si basa sia sulla libertà di pensiero che sulla libertà di parola. I pilastri di una società libera sono, quindi, la libertà di mantenere sistemi di credenze opposte e la libertà di esprimerli. Per costruire una società libera, quindi, dobbiamo a) capire in cosa crediamo e b) poter comunicare le nostre convinzioni al mondo intero. Scrivere può rappresentare un modo più valido di comunicare del dialogo parlato per ottenere questo fine, perché ci permette di esplorare ed esprimere la profondità della nostra mente.
Nell'era dell'individualismo americano, in un universo postmoderno che ha destabilizzato la verità oggettiva, nell'epoca dei fact-checker di parte e delle fake news, in un tempo che il filosofo tedesco Oswald Spengler definì “faustiano” per la sua ricerca individualistica della conoscenza - in un mondo, in breve, in cui prevalgono idee diverse e contraddittorie, è più importante che mai comprendere i nostri sistemi di credenze individuali.
La libertà, dopo tutto, è un'arma a doppio taglio. Quando esercitiamo il nostro potere di espressione, di fatto resistiamo a chi ci vuole dire in cosa e in chi credere. Per continuare a promuovere la libertà, ognuno di noi deve capire in cosa crede e sviluppare la capacità di trasmettere le proprie convinzioni agli altri.
Ed è qui che entra in gioco la scrittura. Essa costituisce un potente veicolo attraverso il quale possiamo, per usare le parole dello psicologo Jordan Peterson, “scoprire ciò che crediamo sia vero”. Nell'età moderna, la scrittura è diventata uno dei pochi modi in cui possiamo confrontarci in modo coerente con l'esperienza soggettiva e tradurla in certi valori. Quindi, elaborati i nostri valori, dobbiamo cercare di comunicarli al mondo. Dopo tutto, una società che promuove tanti valori diversi funziona solo se questi valori soggettivi vengono tradotti in qualche manifestazione della realtà. La scrittura è lo strumento adatto, una forma tangible di espressione che rimane iscritto nel mondo materiale. Rappresenta un ponte dai nostri pensieri più reclusi e complessi a colori che li leggono. La scrittura porta la nostra consapevolezza nella realtà.
La scrittura, in altri termini, è l'unico mezzo con cui possiamo sperare di essere compresi. Mentre l’illusione di uno spirito collettivo si allontana, e mentre navighiamo in quello che lo psicologo Jonathan Haidt definisce “il mondo dopo Babele” - dove non ci capiamo più l'un l'altro, come se parlassimo tutti lingue diverse - dobbiamo cercare, in qualche modo, di comunicare al mondo le nostre riflessioni soggettive per trovare unità e coesione.
Anche se Platone sarebbe potuto rimanere sconvolto dal disprezzo della nostra cultura nei confronti della realtà oggettiva, forse avrebbe osservato che, nonostante ciò, utilizziamo la scrittura come strumento per arrivare alla verità, per quanto si tratti di un processo errato secondo la sua prospettiva. In un mondo che si allontana nettamente dall'Atene più omogenea di Platone, in un universo in cui siamo liberi di giocare con le idee, la scrittura – mezzo di trasmissione dello spirito soggettivo che serve a dare un senso alla realtà - è la chiave per nutrire una società libera.
Imparare a scrivere nell'era moderna non significa battere ChatGPT – questa capacità è uno dei prerequisiti fondamentali per uno sviluppo intellettuale avanzato, che inauguri un mondo dove abbondano le opinioni contraddittorie, ma in cui argomentazioni e verità possono essere raggiunte attraverso questo mezzo. Poiché l’abilità di comunicare con forza e autenticità è ormai sempre più rara, al mondo libero servono sempre più grandi scrittori che abbraccino il proprio talento e non ne fuggano.
Se impari a scrivere, sarai la persona che Platone ha sempre temuto: il ribelle con il potere di cambiare la società.
Liza Libes è una scrittrice che ha creato la pagina Pens and Poison.
Seguici sulle pagine social per più aggiornamenti su X e Instagram.